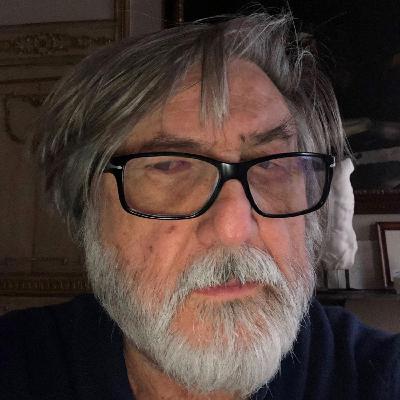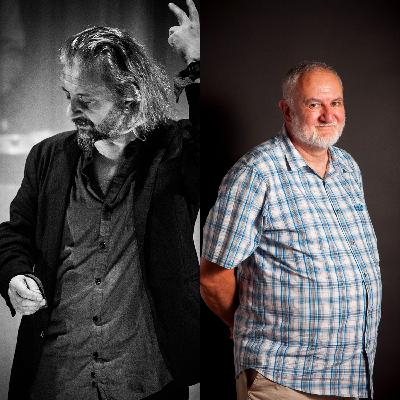Discover Dialoghi di Pistoia | Lezioni e conferenze
Dialoghi di Pistoia | Lezioni e conferenze

Dialoghi di Pistoia | Lezioni e conferenze
Author: A cura del festival di antropologia del contemporaneo
Subscribed: 40Played: 1,882Subscribe
Share
Description
Un nuovo modo nuovo di fare approfondimento culturale, con taglio antropologico, e con nuovi sguardi sulle società umane: 200 lezioni, dialoghi e conferenze di studiosi e esperti con letture inedite del mondo che ci circonda sui temi: identità, corpo, dono, viaggio, incontro, condivisione, abitare, gioco, cultura, creatività, convivenza, linguaggi.
"I Dialoghi stanno compiendo un percorso per meglio comprendere la realtà che ci circonda, spinti dall’interesse per gli altri e per le altre culture, nella consapevolezza di essere su una imbarcazione comune, in un viaggio antropologico attorno all’umanità."
Giulia Cogoli, ideatrice e direttrice dei Dialoghi
Web: www.dialoghidipistoia.it
Promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia
"I Dialoghi stanno compiendo un percorso per meglio comprendere la realtà che ci circonda, spinti dall’interesse per gli altri e per le altre culture, nella consapevolezza di essere su una imbarcazione comune, in un viaggio antropologico attorno all’umanità."
Giulia Cogoli, ideatrice e direttrice dei Dialoghi
Web: www.dialoghidipistoia.it
Promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia
291 Episodes
Reverse
Le montagne sono al centro di un dibattito sull’abitare e sugli abitanti: pendolari, di passaggio, nuovi, rimasti, immigrati per forza o per scelta, corteggiati o acquisiti controvoglia. Se prima si parlava di spopolamento oggi si registrano i primi segni di una nuova tendenza, ma cosa cerca e, soprattutto, cosa trova oggi chi sale in montagna? Le terre alte dell’antropocene sono molto diverse da quelle abbandonate ottant’anni fa: sono più connesse, più infrastrutturate, più ricche ma anche più incolte e boscose, più cementate, frequentate e siccitose. Il paesaggio e chi lo abita – residenti umani e non umani – si sono trasformati profondamente, ma l’immaginario alpino continua a dominare proponendo immagini e retoriche vecchie e dannose. Cosa muove chi sale inseguendo stereotipi anacronistici e cosa lo aspetta in luoghi che somigliano sempre meno alle cartoline patinate che li ritraggono? Sono pronte le montagne a ospitare chi vorrà sfuggire al clima invivibile delle città, sono resilienti abbastanza da sopportare il carico turistico di chi già le frequenta ormai in ogni periodo del giorno e dell’anno, con ogni mezzo e senza alcuna consapevolezza del proprio impatto?
Il cambiamento climatico non è più alle porte, è ormai dentro casa nostra: la Terra. E questa sorta di tempesta ambientale trasformerà le nostre esistenze. Nei prossimi cinquant’anni temperature più elevate e l’aumento dell’umidità renderanno vaste aree del pianeta invivibili. Le genti che le abitano saranno costrette a cercare rifugio altrove, in regioni più fresche. Il secolo che verrà sarà segnato da un nomadismo di massa: cosa comporterà questo esodo di popolazioni? Quali le conseguenze? Di questo discuteranno Gaia Vince, scienziata e giornalista scientifica, autrice de Il secolo nomade e l’antropologo Marco Aime. Quali risposte potremo e sapremo dare? Cosa comporterà questo terremoto demografico? I quesiti sono molti e il tempo stringe, per questo è importante conoscere i termini della questione, per affrontarli al meglio. Traduzione di Marina Astrologo.
Alle virtù del turismo si crede come a una religione, ma dove arriva il turismo, dopo un po’ non cresce più niente. Lo slogan del “turismo petrolio d’Italia” è un modello estrattivo e coloniale, che usa i luoghi come giacimenti di persone e risorse da sfruttare, uno strumento non per produrre ma per estrarre ricchezza dai territori, dai paesaggi, dalle comunità che li abitano, dalle loro culture e identità. E se il turismo genera ricchezza, bisogna sempre chiedersi: per chi? E chi paga i costi economici, sociali e ambientali del turismo? Il salto di scala compiuto negli ultimi vent’anni è oggi così problematico da giustificare misure securitarie per gestire i flussi in ambienti fragili: il turismo è diventato un problema di ordine pubblico, e di rottura delle relazioni dell’abitare per trasformare territori in luoghi di vacanza e di consumo, per venderli come merci. Bisogna necessariamente partire dal basso, dalle persone che abitano i luoghi, che vi entrano in relazione, che ricostruiscono contesti e ne progettano il futuro.
Siamo una specie nomade, siamo migranti inquieti e irrequieti. Le società nomadi del passato e dell’altrove non sono curiosità esotiche: ci aiutano a capire i nuovi nomadismi. Ad esempio i due tratti caratterizzanti delle società polinesiane erano “partire” e “accogliere”. Partire per trovare nuove isole, per sfuggire a cicloni e guerre o semplicemente per il gusto del viaggio. Accogliere per non morire di chiusura e di consanguineità biologica e mentale. Gli antichi nomadismi ci aiutano a capire quelli contemporanei, della generazione Intercultura ed Erasmus, e quelli di una ancora più giovane generazione di studenti e lavoratori che fanno della circolarità e del movimento il loro stile di vita. Partono, accolgono e sono accolti. Come gli antichi polinesiani dovevano praticare la frugalità portando sulle loro piroghe tutto il necessario per sopravvivere su un’isola ancora sconosciuta, così i nomadi digitali di oggi viaggiano con valigie digitali (PC, chiavette, cloud) e con pochi oggetti d’affetto. I nomadi di ieri e di oggi sono accomunati da una “fede”: l’interdipendenza che ci lega agli altri, il superamento dei confini, il prevalere dell’orizzonte sulle piccole patrie.
Viviamo in un mondo sempre più frammentato dove è molto frequente sentirsi isolati, soprattutto per i più giovani. Per questo gli adolescenti odierni ricercano gli adulti in modo più autentico rispetto al passato. Questo atteggiamento richiederebbe una postura più responsabile da parte di tutti noi, che siamo, invece, impegnati a sostenere che le nuove generazioni abbiano avuto troppo e siano state troppo amate. A quel punto meglio Internet, dove i giovani si rifugiano per lenire il dolore provocato dalla perdita della speranza, dal sentirsi soli in mezzo agli altri, senza condivisione e convivenza. Una nuova posizione adulta è invece oggi possibile. La capacità di identificarsi con i bisogni evolutivi generazionali e l’offerta di relazioni autentiche consentono alle ragazze e ai ragazzi di crescere e credere nella realizzazione di sé nel mondo attuale e futuro. È suonata la campanella, inizia l’ora di relazione. Lo psicologo Matteo Lancini ci parla di relazione e della responsabilità che gli adulti hanno verso le future generazioni.
In collaborazione con Fondazione Hapax - Synapsis
L’architetto Ferdinando Fagnola, esperto di architetture tradizionali saheliane, ci propone un ricco e suggestivo viaggio tra le più antiche architetture in terra cruda dell’Africa subsahariana. La realizzazione di tali costruzioni, che vanno dalle semplici capanne a grandi edifici, come alcune moschee di Timbuctù o Djenné, sono testimoni di antiche culture, profondamente radicate nell’ambiente, che danno vita a costruzioni che dialogano con la natura, invece di opporvisi. Un modo di abitare che si coniuga con l’ambiente, integrandolo, che fonde elementi fisici con elementi culturali, infatti, queste forme diventano una sorta di scrittura nello spazio al punto che vi si possono leggere molti elementi legati alla dimensione spirituale delle popolazioni che le hanno erette.
Muraglie di terra è il titolo di un celebre romanzo storico scritto da Maryse Condé, ambientato nel Mali del secolo scorso. Il titolo che richiama la pratica, diffusa tra Sahel e Sahara, di costruire edifici con l’unico materiale disponibile: la terra. Una pratica che richiede profonde conoscenze e tecniche costruttive e che smonta un altro tassello dell’immagine di un’Africa “arretrata”.
L’architettura della casa viene “inventata” nel Novecento, in un continuo equilibrio tra urgenza abitativa e nuovo status sociale. Nel corso del secolo cambia l’idea di abitare e la casa si adatta, si declina, si articola in nuove soluzioni. La cultura dell’abitare in Italia si muove tra la spinta del moderno e il riconoscimento della tradizione, mentre in Europa sono tante le forme di sperimentazione più spinta, fino ai più recenti casi di co-housing. È lo spazio il grande artefice della vita degli interni, che verrà indagato nei suoi tanti aspetti, offrendoci una riflessione che ci aiuti a interpretare l’abitare contemporaneo.
La maggior foresta tropicale del pianeta è il luogo in cui abbonda la biodiversità e abitarvi significa convivere con un’infinità di specie non umane. È un ambiente originario, uno dei pochi luoghi del pianeta che sembra aver resistito alla forza trasformatrice dell’homo sapiens. Ma come si vive in un piccolo villaggio dell’Amazzonia remota? Sessanta persone, sedici palafitte, canoe parcheggiate sulla riva di un fiume, una sconfinata foresta intatta tutto intorno. Cacciatori e raccoglitori vivono, anzi sono, la comunità naturale di cui fanno parte, condividono con le altre specie spazi e risorse, collaborano. E ci offrono una visione del mondo di grande ispirazione.
Quanto impatta sulle ecologie urbane la crisi climatica e i suoi effetti sulla salute? Il benessere e la qualità delle relazioni? Che cosa succede alle nostre città se da luoghi dell’abitare e del lavoro diventano piattaforme per produrre rendite e profitti? Cosa succede nelle nostre vite se viene messo in discussione il diritto a stare e il diritto all’abitare? Continuare ad abitare le città significa oggi in primo luogo riuscire a immaginare e sperimentare percorsi di cambiamento. Ci sono nuovi bisogni diffusi (come il bisogno di natura e di salute), nuovi modi di abitare (soprattutto in quel “terzo tempo” liberato dal lavoro), una mutazione profonda dei tempi di lavoro e di vita che sollecitano con urgenza una trasformazione delle città.
Sempre più soli e chiusi in noi stessi viviamo l’amicizia come una questione privata, intima, che ci unisce solo a chi “ci somiglia” e non ha niente a che fare con la politica. Abbiamo dimenticato la lezione di Platone e Aristotele sulla philia che è “messa in pratica del bene” e condizione perché si dia una vera polis, intesa come lo spazio di coesistenza con chi è diverso da noi. Coltiviamo invece il mito dell’identità personale – da qui il dilagare del narcisismo – e collettiva – da qui l’ascesa dei sovranismi, dei muri e del mito della frontiera chiusa – in una società atomizzata e altamente competitiva dove gli altri sono ridotti a presenze minacciose, avversari o spettatori delle nostre performance. Il filosofo Pietro Del Soldà ci invita a riscoprire l’amicizia come essenza dell’umano, il primo passo per imparare a convivere con le differenze e a non distruggere la terra fragile di cui siamo figli.
La diffusa retorica dei “borghi”, con le loro storie antiche e paesaggi da favola, ha posto in secondo piano la centralità dei “paesi”, fatti di persone, economie, comunità e relazioni. L’Italia, dalle aree interne, fino alle città medio-piccole, alle aree rurali e alle coste, è oggi costellata da molti esperimenti di innovazione sociale: comunità energetiche, forme di agricoltura rigenerativa, gruppi di acquisto solidale. Esperimenti che mettono al centro la complessità dell’abitare, fatta di relazioni, significati e capacità collettiva di proiettarsi nel futuro. La costruzione di tessuti sociali ricchi di relazioni significative, di nuove economie e di forme di comunità locali e rispettose delle diversità territoriali, possono costituire modelli per un futuro diverso dal solo investimento in turismo.
La crisi ecologica e il cambiamento climatico ci chiamano a una radicale rilettura del ruolo di design e architettura, ispirata alla saggezza costruttiva di piante e architetture animali, per delineare un orizzonte di futuro sostenibile. Le mirabili creazioni di api, termiti, uccelli e innumerevoli altre specie offrono un repertorio inestimabile di strategie di adattamento, efficienza e simbiosi con l’ambiente. Quali lezioni possiamo trarre dalle loro tecniche costruttive, dalla sapiente selezione dei materiali e dalle raffinate strategie di adattamento climatico? Come possiamo traslare queste conoscenze nel design umano, dando vita a edifici e spazi che trascendano la sola funzionalità per divenire agenti di rigenerazione? Proponendo un design che si ponga come strumento di riparazione della biosfera. Abbandonando la logica predatoria della sovrapproduzione, progettando con responsabilità e rispetto per ogni forma di vita. Ripensando le fondamenta del nostro abitare. Trasformando il progetto in un atto di cura e rigenerazione per il pianeta.
Abitare ai limiti, ai margini delle città, della vita che pulsa nei centri, è un vivere minore? «L’uomo è organizzatore dello spazio» scriveva il grande paleontologo André Leroi-Gourhan e nell’organizzare i nostri spazi, spesso utilizziamo il modello “centro/periferia”. Il centro è l’origine, il luogo dove tutto accade, le periferie sono marginali, secondarie. Eppure se usiamo la metafora della ruota, non è dal centro che si percepisce il movimento, ma dalla periferia. Su questa falsariga Ascanio Celestini, che da sempre mette in scena i marginali, i “poveri cristi” e l’antropologo Marco Aime, dialogheranno, per tentare di ribaltare una serie di luoghi comuni e di spostare lo sguardo. Per esplorare lo stare al mondo, bisogna partire da chi abita ai limiti, da microcosmi di solidarietà, esercizi di convivenza per provare a respingere egoisimi e miopie.
David Quammen, camminando per centinaia di chilometri nelle foreste, nei deserti e nelle tundre al seguito degli esploratori, ha indagato il cuore pulsante della natura selvaggia, oggi depredato e in agonia, raccontando come l’impatto della colonizzazione umana abbia influito sugli habitat più isolati e primitivi. Intervistando centinaia di esperti aveva previsto anni prima (nel bestseller mondiale Spillover) in ogni dettaglio la pandemia da Covid-19. Quammen e Pievani dialogano sulla convivenza possibile tra la specie umana e il resto della biodiversità, poiché «siamo tutti legati in un’unica rete», come scrisse Charles Darwin, lo scienziato che più di tutti ha ispirato il lavoro di entrambi, colui che concepisce nella sua mente a rivoluzione scientifica e poi si spaventa e la tiene nascosta per più di vent’anni. Un evoluzionista riluttante. Traduzione di Marina Astrologo.
Chiara Saraceno, una delle più autorevoli sociologhe, tra i protagonisti più attenti e profondi della nostra società, vince la VIII edizione del Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, conferito a una figura del mondo culturale, che con il proprio pensiero e lavoro abbia testimoniato la centralità del dialogo e della cultura per lo sviluppo delle relazioni umane. Chiara Saraceno parlerà di come convivere in una società, come la nostra, segnata da diversi tipi di disuguaglianze: economica, di genere, di cittadinanza, culturale, di valori? Disuguaglianze che sembrano contraddire quella che dovrebbe essere una società democratica. Le disuguaglianze vanno limitate e le loro cause affrontate. Le differenze, che spesso ci allontanano, invece di essere cristallizzate in una reciproca incomunicabilità, dovrebbero trovare spazi e modi di confronto, di contaminazione, nel rispetto delle libertà individuali. Se le disuguaglianze e le differenze diventano gabbie autoritarie e violente, le libertà di tutti sono minacciate.
Il carcere può essere considerato una casa in cui si “abita”? La letteratura classica sulle istituzioni penitenziarie pone l’accento sulla netta distinzione tra lo spazio fuori e lo spazio dentro: ostile, anonimo, impersonale; il tempo dentro: sospeso, improduttivo, eterno. Recentemente però, ricercatori e ricercatrici hanno esplorato una serie di carceri in un certo senso “addomesticate”. Le loro analisi, a partire dall’esperienza delle persone recluse, saranno l’oggetto di un viaggio “nel ventre della bestia” come è stato definito nel famoso libro di Jack Abbott, in cui sbarre, cancelli e immobilità non sono più le componenti principali ed essenziali per definire l’incarcerazione, favorendo una nuova comprensione dell’esclusione e dell’isolamento.
Il Novecento per l’Italia è stato il secolo delle cose, tanto che non è possibile raccontare il XX secolo, la storia d’Italia, degli italiani e delle italiane, senza raccontare i tantissimi oggetti che, decennio dopo decennio, hanno dato forma ai salotti, alle case, alle piazze e ai costumi di un Paese, di fatto costruendo l’immaginario di ciò che abitiamo. Partendo dalle piccole storie dietro le cose, e dalle grandi persone che ne sono state protagoniste – disegnandole, inventandole e progettandole – Chiara Alessi, studiosa di design e cultura materiale, attraversa fatti politici e movimenti sociali, eventi culturali e storia materiale, in un rimbalzo continuo tra oggetto, contesto e persone, per aiutarci a capire chi siamo attraverso le cose.
Viviamo un’epoca che credevamo scomparsa nei meandri del passato. I venti di guerra sembrano tornare a soffiare anche sull’Europa, che ritenevamo essersi scrollata quel pesante e triste fardello. In realtà, al di là delle nostre frontiere, le armi non hanno mai cessato di tuonare. Francesca Mannocchi, da anni è la testimone più sincera e accorata di cosa significa vivere e sopravvivere in una condizione di guerra. Dal Medio Oriente all’Africa e all’Ucraina, Mannocchi racconta storie di vita, piene di umanità, di un’umanità distrutta, che a volte riesce a trovare la forza di andare avanti, anche sotto il rumore degli spari.
L’evoluzione non vede il futuro, avviene nel qui e ora. Può quindi succedere che una specie esaurisca le risorse disponibili e metta a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Che stia accadendo all’unica specie auto-proclamatasi “sapiens”, tuttavia, è paradossale. Questa crisi del nostro stare nel mondo naturale ha radici profonde. La socialità umana per piccoli gruppi sta faticosamente allargando lo spettro del “noi”: dalla tribù alla città, dalla città a un popolo, da questo all’umanità intera e alla biosfera. Viviamo accanto a moltitudini di estranei solo da poche migliaia di anni. Per contro, le forze che strumentalizzano i nostri egoismi di gruppo sono sempre più potenti. Dinanzi a sfide globali, ci stiamo illudendo tragicamente di uscirne attraverso sovranismi conflittuali, minando tutte le istituzioni sovranazionali. Quando una specie cambia il mondo in modo tale da ridurre le possibilità di benessere delle generazioni successive, si parla di “trappola evolutiva”. Per uscirne, la prima condizione è esserne consapevoli e riscoprire il valore essenziale della cooperazione.
Quando ci si riferisce a qualcosa di “alto”, che sia moda, design oppure cucina, immediatamente gran parte di noi si sente esclusa, pensa ad abiti, oggetti e ristoranti riservati a pochi eletti, a stili di vita cristallizzati con rituali e costi che li rendono inaccessibili. Invece, Cristina Bowerman, chef (una stella Michelin) ha lavorato sulla trasformazione dell’alta cucina in un’esperienza accessibile, che non crea isolamento (i tavoli distanziati, il servizio di formalità raggelante) bensì apertura a ingredienti e ricette che non hanno frontiere, con prezzi accessibili e con sconti per i clienti più giovani, con percorsi di degustazione libertari (si possono usare le mani e non solo le posate), e con l’apporto di un servizio empatico, per nulla sussiegoso. La sua declinazione dell’alta cucina è anzitutto un’altra cucina, priva di tabù.